Pioggia di fine estate
Bentornati amici miei, vivi e morti… poi capirete perché. Questo è un vecchio racconto scritto ormai tanti anni fa, raccolto in quel “cimitero delle buone intenzioni” che è diventato il mio Quotidiano d’Ombra. E che spero vi piaccia. A essere sinceri non è stato divertente scriverlo, perché ho preso ispirazione da una cosa accaduta davvero nel mio paese, dopo il peggior fatto di cronaca avvenuto qui nei primi anni ’90. Un fatto tanto famoso in tutta Italia che non voglio parlarne. Un vuoto tanto grande che mi fece capire cosa significa perdere la ragione. Ma adesso non siate troppo tristi, in fondo leggere è un po’ come fare l’amore con qualcuno che non avete ancora conosciuto… divertente, no?
Buona lettura piccoli necrofori!!
Il mio mestiere è fare il Beccamorto.
Sono il necroforo del paese. Quello che controlla che i morti rimangano morti. Quello che scava le buche e veglia l’eterno riposo dei vostri cari. Mi piace il mio lavoro perché gli ospiti sono tranquilli e non disturbano mai e quando dico mai è davvero mai. Lo so che posso sembrare macabro, ma sono felice del mio mestiere perché è immerso nel silenzio, nella pace eterna di chi ci guarda prima di varcare le soglie dell’aldilà e perché la morte non mi fa paura. La morte è come una vecchia signora democratica che non parla mai e quando lo fa, non dice mai nulla fuori posto.
Sono un uomo sereno che ama le cose semplici e la pace che trasmette il cimitero mi calma i sensi, mi fa sentire come se potessi vedere oltre l’orizzonte al di là delle nuvole, oltre i confini dell’universo, dove gli occhi smettono di vedere per incominciare a guardare, e credo che a volte da qui si riesca a superare il confine noto per andare in un oltre ignoto.
I cimiteri sono l’ultima dimora nota che abbiamo sulla terra, ma non credo sia l’unico posto in cui siamo veramente: credo sia possibile che i morti camminino accanto a noi. O almeno è quello che mi piace credere. Tanto per credere in qualcosa.
La morte ha delle conseguenze per tutti quelli che la subiscono: porta con sé l’incomprensione dell’ignoto e il faticoso fardello di un ricordo che pian piano diventerà sempre più sbiadito, informe, delicato, anche se si lotterà per mantenerlo vivo come il primo giorno. Sarà inevitabile, il tempo cancella la vivacità del colore, lo fa per consentirci di vivere fino al nostro di momento, fino a che non tocca a noi. Abbiamo il diritto di andare avanti e di farlo al meglio delle nostre possibilità per chi è vicino ed anche per chi non c’è più.
Vedo tante cose stando qua: a volte anche le cose belle. Perché ad un certo punto il ricordo prende il posto del dolore, del rimorso e della colpa. Si smette di essere in collera con chi è morto e si ricomincia a vivere. E a ridere col cuore. Vedo persone abbracciarsi, cercare di galleggiare in un dolore che può anche occupare troppo spazio, ma queste persone ci provano lo stesso. Perché se lo meritano e perché ne hanno bisogno.
La morte è solo un rito di passaggio, un veloce secondo, dove tutto diventa prima molto luminoso e poi nero, ma quando il buio si dirada si scopre che non si è nel nulla assoluto e che ancora qualcosa di noi resta. Almeno è quello che mi è stato insegnato nel tempo.
Le persone sono costruzioni complesse composte da neuroni, cellule, nervi, vene, ossa e muscoli.
Quando si muore diventiamo tutti la stessa cosa: polverosi resti. Se siamo stati bravi avremo la fortuna di vivere in chi ci ha amato e in chi abbiamo generato, non saremo solo un ricordo lontano nella mente di Dio. Credo che il mio lavoro sia come quello dello psichiatra; vedo, ascolto, sento e cerco di capire. Anche se ho la sensazione che la diagnosi sia uguale per tutti, sacra paura di non essere più nulla e di morire finendo nel buio. Non siamo ancora pronti: non siamo mai pronti.
Ho visto tante cose da qua e ho vissuto dentro tante storie senza che i protagonisti se ne rendessero conto, ho sentito tante emozioni passarmi accanto, ma se ripenso a questi dieci anni, una sola storia mi ha, come dire, portato dentro se stessa, risucchiato nella follia e sbattuto davanti al cancello che conduce ai confini della realtà.
Il mio è un cimitero molto particolare: nonostante sia una piccola cittadina ospita tutte le vittime del caso delle “Mercedes dorate”, un fattaccio che preferirei non rammentare, ma che ogni tanto qualcuno rispolvera. Riposano, o almeno tentano di farlo, troppo vicini l’uno dall’altra. Ma non voglio raccontare una storia che di certo conoscete meglio di me.
Voglio raccontarvi una storia perché è strana, incerta e crudele: insomma, in una parola è reale. E’ talmente strana che a volte ho la sensazione di averla sognata, che sia di qualcun altro e che adesso nel dirla ad alta voce si dissolva in una nebbia colorata.
Ve l’ho detto che fare il beccamorto è un lavoro particolare, ma anche interessante. Ne succedono di cose e questa forse è davvero successa solo nei miei sogni. Un sogno davvero brutto, ad essere onesto. Uno di quelli che fai dopo un bicchiere di troppo all’osteria dell’Atomica.
A volte la morte porta con sé la follia e dico quella estrema, totale, che annienta tutto il resto e conduce nei neri abissi cantati da poeti maledetti.
A volte semplicemente si manda il cervello in ferie, per non finire in un oblio oscuro. Ci si chiude dentro a doppia mandata per continuare come se nulla fosse.
Mi resi conto di che cosa significa “sbiellare” un pomeriggio d’estate.
Era l’estate di otto anni fa, un’annata molto piovosa e umida. Sembrava che il cielo scaricasse la rabbia e il dolore accumulati in anni d’attesa di qualcosa mai arrivata.
Un pomeriggio dietro l’altro per dieci giorni.
Quel pomeriggio il cielo era grigio piombo, pieno d’acqua, pronto a esplodere ogni attimo, un cielo da film horror umido e fetente. Quando vidi per la prima volta quella cosa.
La donna stava lì con l’ombrello accanto al corpo, un ombrello grande con gli spicchi dai colori sbiaditi per il troppo uso; lo teneva accanto a se, percepiva che la guerra lassù stava per scoppiare ed entro pochi secondi lo avrebbe aperto. Così accadde.
Non coprii il suo corpo palesemente emaciato e malamente nascosto da abiti leggeri, ma troppo grandi per quella figura che pareva provenire dalla trasparenza delle acque profonde. Coprì con un gesto scattante la tomba accanto a se. La furia della pioggia d’estate le si rovesciava addosso con forza, ma la donna sembrava non rendersene conto o forse non le importava. Avevo come la sensazione che la pioggia le passasse attraverso, ma fu solo un attimo veloce, un lampo che cercava di squarciare il buio del pomeriggio per portarmi dentro un mondo a me sconosciuto.
Guardando quelle spalle curve e quel braccio teso a coprire il marmo bianchissimo della tomba avvertì come il rumore di una catena metallica che cade schiantandosi a centinaia di chilometri dal luogo della rottura con un rimbombo assordante.
Capii con forza il termine ”sbiellato” in cinque secondi netti: è quando la mente vacilla tremando sul baratro con le vertigini e si attacca al primo ramo apparentemente forte che trova.
Quel ramo nel caso della donna era l’ombrello colorato a riparo dei resti terreni della cosa più sacra che avesse mai avuto.
Stava coprendo la tomba dell’unica figlia donatale da Dio, morta a quindici anni, uccisa da un automobilista strafatto mentre andava a scuola in una mattina di Dicembre fredda e piovosa, morta sull’asfalto grigio come il cielo e l’acqua polare dell’inverno, morta senza un perché.
Riparare, difendere la fragilità della figlia, pensare solo a che non si buschi un raffreddore a tre metri sotto terra. In fondo aveva solo un angelo triste dalle ali piegate come protezione, con lo sguardo al suolo per osservare e preservare il sonno della bimba morta quasi donna.
Una delle cose più strazianti che abbia mai visto.
In quel pensiero non formulato dalla testa, ma dallo stomaco, capivo l’enormità della morte, l’eternità del suo significato, l’inesplicabile e invincibile potenza con cui si abbatte sul mondo, sui mondi delle persone comuni. Un atto di accusa rivolto a Dio e a tutti gli uomini che frettolosamente passano, un urlo d’amore prodotto da corde vocali rassegnate al destino muto dell’inspiegabile.
Succedeva una cosa strana ma in quei momenti non me ne rendevo conto. Forse a livello cosciente non lo avevo registrato o era solo una mia impressione, ma credevo di vederla solo io, come se solo io potessi custodire il dolore assurdo di quella poveretta disperata, avevo la sensazione che le persone non vi prestassero attenzione.
Stavo guardando dentro all’abisso della follia di una madre, mi sentivo come un naturalista che seziona la farfalla o un patologo che seziona un cadavere. E il patologo era certamente la cosa più vicina e consona.
Avevo il biglietto di sola andata per un viaggio allucinante e pericoloso dentro un luogo molto impervio, con un pavimento dalle tavole sconnesse dove gli scatoloni pieni di vecchi giocattoli impolverati saltano fuori e ti guardano con fare malevolo. Mi sembrava di sentire il suono di quegli scimpanzé a carica che battono i piatti. L’unico problema era che i piatti cadendo dallo scatolone si erano sbrecciati e quindi a ogni colpo era come sentire un’orchestra di ubriachi.
Ecco cosa mi sembrava di sentire vedendo quella donna: un’orchestra infernale che ha un direttore con un braccio solo.
Oltre l’arcobaleno invece degli gnomi e la loro pentola piena d’oro c’è solo la cassa da morto di una studentessa morta troppo presto.
Provavo una fitta allo stomaco come quelle provocate dal the ghiacciato bevuto troppo in fretta, sentii un grido insonorizzato salire e scendermi lungo l’esofago, ogni volta che vedevo le spalle curve della donna, avvertivo come della ghiaia ferroviaria nella pancia. Volevo urlargli di andare a casa, di coprirsi sennò si sarebbe ammalata, di piangere nel buio del suo bagno. Volevo solo che sparisse dalla mia vista. Perché ero un ragazzino vigliacco e mi straziava vederla così. Una perfetta sconosciuta aveva intersecato il mio mondo di baldorie senza fine buttandomi a terra col culo sull’asfalto bagnato. Non potevo sopportarlo.
Per il resto il mio lavoro scorreva come al solito, e per fortuna dovetti scavare meno buche per ragazzini anche se i vecchietti non mancavano, forse a causa dell’umidità.
Le cose scorrevano scivolose e leggere come ogni estate; avevo solo ventidue anni ed era il mio primo vero lavoro: avevo iniziato due anni prima e diciamo pure che non ero un grande veterano ma capivo che la stranezza era piombata nella mia vita. I miei giorni in quel periodo erano gli stessi di sempre ma avevo la sensazione che tutto stesse cadendo giù, le cose cercavano di rotolare verso il fondo del pozzo nonostante io non scivolassi: io ero lì ben saldo sulla terra.
Al pomeriggio spesso stazionavo in ufficio a bere limonata ghiacciata rimanendo in osservazione. Potevo starmene ore a guardare l’umanità variegata e variegante che popolava quel luogo senza mai annoiarmi. Il cimitero è quel posto dove puoi andare lasciando a casa la ragione e portando con te solo la scimmia cattiva che vive sulla tua spalla, a nessuno frega un cazzo se parli da solo o piangi, nessuno verrà a chiedertene il motivo, perché la comunanza rende tutti uguali. Il cimitero è il luogo del silenzio e delle domande senza risposta e a tutti va bene così.
La strana donna arrivava alle quattordici e trenta spaccate e se ne andava alle sedici e zero due, cascasse il mondo, lei era puntuale come uno svizzero col suo ombrello di fianco e lo sguardo basso come se dovesse stare attenta a dove metteva i piedi. Passava veloce tra le persone senza salutare nessuno, come se nessuno la conoscesse. Eppure la ragazzina era del posto, me la ricordavo di vista quando passeggiava con le amiche, non era tanto più giovane di me e a dire il vero la trovavo davvero molto bella.
Fa uno strano effetto seppellire persone che vedi tutti i giorni o che conosci bene. Gettare terra e murare per sempre i corpi dentro ai “loro appartamenti” come diceva il buon vecchio Cerletti, ora pensionato dopo quarant’anni di lavoro sempre qui nel cimitero, anno dopo anno. Chissà se riuscirò anch’io a starmene qui a fare lo stesso lavoro o se mi capiterà qualcosa come accadde a Stefanelli due anni fa.
Una mattina il vecchio Stefanelli si è svegliato come ogni giorno per venire a lavorare, ma quella volta i suoi programmi cambiarono drasticamente: impugnò il fucile da caccia appartenuto al fratello morto l’anno prima per infarto ed entrò nella stanza da letto dove la moglie Luisa stava dormendo e le sparò in faccia. Erano sposati da ventisei anni. Poi prese una corda per il bucato e s’impiccò in garage lasciando una lettera nel suo armadietto qui al lavoro. Diceva che doveva farlo perché le voci di tutti gli abitanti del cimitero lo chiamavano, volevano che lui e la moglie andassero a vivere lì per sempre.
Stefanelli si è ucciso perché ha sbiellato. Esattamente. Ha fatto proprio quello che sto raccontando.
Ha chiuso la porta per smettere di sentire le voci, si è barricato dentro con lo stereo a tutto volume ed ha sparato per fare più casino delle voci sperando che avrebbero smesso di parlare e urlare. Ha chiuso dentro la scimmia e fuori tutti gli altri ed è andato all’inferno.
Lo seppellimmo io, Cerletti, Santi, Domenichini e Dondarini: Lo staff al gran completo.
Eravamo distrutti e disperati perché eravamo nudi davanti a una tragedia così grande da sembrare falsa, scritta da uno sceneggiatore di Hollywood e mai girata, solo provata; eravamo indifesi e malati, impreparati ad un evento così pazzesco e senza senso, non aveva davvero confini quello che era successo e ci faceva un gran male.
Credo che tutti si rendano conto della morte dei propri cari nel momento in cui sentono il rumore della terra che colpisce la bara dentro la fossa, prima la mente cerca di rimuovere il fatto che dentro a quelle tavole di legno finemente cesellate ci sia un cadavere, che mai più potrà riavere vita, aprire gli occhi o camminare, sorridere, arrabbiarsi. Nell’attimo in cui la terra smossa cade come pioggia su quella scatola, allora e solo allora si capisce cosa sta succedendo.
Si comprende che una parte del viaggio è finita e che tutto sarà inevitabilmente diverso.
Noi ci sentivamo così, come se fosse la prima fossa della nostra carriera ed eravamo un po’ laggiù con lui senza il desiderio di tornare in superficie.
Ma la vita è così: tira brutti scherzi che a volte fanno male e fa montare una rabbia melmosa, come la marea nera che cerca di uscire la notte da buie lagune.
Otto anni fa Stefanelli non parlava ancora con i morti e Cerletti era ancora lontano dalla pensione. Mi davano spesso il cambio o io lo davo a loro, ma non dissi mai nulla su quello che provavo.
Non che sia molto timido, ma non so perché non potevo dire a nessuno cosa vedevo e provavo in quegli strani giorni.
Non lo dissi nemmeno ad Amanda che sei anni dopo sarebbe diventata mia moglie, anche se credo che lei sentisse qualcosa, credo avesse già capito che qualcosa si stava sedimentando sul mio cuore. Credo sapesse qualcosa, lo percepiva, mi stava cesellando, scolpendo; le donne lo sanno ben prima di noi che qualcosa non funziona e se stanno zitte. Lo fanno o per non disturbarci oppure per non spaventarsi troppo.
L’estate piovosa e umida mi portava ogni pomeriggio l’immagine sbiadita di una povera madre sola come una desolata notte invernale; poi un pomeriggio non vidi lei, ma il marito.
Sapevo che era lui perché nella frazione di secondo in cui incrociai i suoi occhi vidi che erano gli stessi della ragazza imbronciata ma felice della foto sotto all’angelo abbattuto. Doveva essere un uomo molto bello e affascinante prima di cadere nella notte eterna: rimase solo pochi minuti, ma furono lunghi come due ere geologiche. Le persone lo guardavano senza il coraggio di avvicinarsi a quell’ammasso di carne che un tempo era stato un uomo fiero e possente, che aveva incurvato le spalle come se avesse compiuto duemila anni. Una donna gli sfiorò con delicatezza una mano mentre se ne andava verso il viale che conduce dentro la parte nuova e l’uomo la abbracciò così forte che credevo la potesse uccidere, poi si addentrò nella calura di quel pomeriggio afoso e senza nuvole. Dopo tanto tempo se ne andò, come era venuto, forse a visitare altre parti del suo passato.
Era come se lo avessero svuotato dal sangue: le guance pallide ed esangui, pelle trasparente come un uovo di serpente rigata dalle lacrime come un proiettile dalla pistola. Il suo volto era un paesaggio del terrore senza speranza alcuna.
Fu una visione desolante che mi lasciò un sottile velo di consapevolezza in più di come la morte sia succeduta dal distaccamento di placche cardiache che cadono rumorosamente nel pozzo senza fondo della coscienza.
Chi muore lascia un’autostrada non asfaltata di perché sul volto di chi ha amato e un senso di lontananza muta e non più colmabile.
Quel padre solo come il più solo del mondo mi fece una strana impressione: era come se vivesse così da sempre e non avesse mai conosciuto nessuno; era davvero la cosa peggiore che avessi mai visto e non chiedetemi il perché.
Non era certo il primo in quelle condizioni che vedevo, ma quello era a suo modo davvero sconvolgente, spaventoso, come se vedesse fantasmi a ogni ora e la sua mente non ne potesse più. Credo che forse li vedesse davvero, anche solo le proiezioni del suo inconscio ormai malandato; quello che sentiva lo stava distruggendo, lentamente, come acqua che scava i sassi.
I miei giorni di ragazzo felice e inconsapevole proseguivano lieti e gagliardi, ogni cosa era illuminata dal sole estivo e dall’amore incondizionato per Amanda. Il mio lavoro mi piaceva e in un certo senso mi divertiva: tutte quelle persone che non sono matte o depravate, ma che si divertono leggendo i vecchi fumetti dello Zio Creepy sanno cosa intendo.
Quando ti piacciono certe cose, le persone ti guardano come se avessero di fronte uno psicopatico pericoloso, una creatura da museo degli orrori. E’ difficile spiegare loro che anche tu ti commuovi, magari per cose che stanno su un piano differente, ma che tu provi le stesse cose e con la loro stessa intensità. Non ho turbe strane e non le ho mai avute, credo che mi divertissi solo perché avevo voglia di vivere, perché ero un ventenne arrapato e in quei giorni era solo tutto più intenso del solito, mi sembrava di essere il padrone del mondo intero.
Ero così giovane, delicato e indifeso nonostante credessi nell’immortalità. Gli altri morivano, ma Andrea Sandri no, lui non poteva morire perché aveva il Super Potere del Beccamorto e quindi conosceva il segreto del faraone immortale. La stupidità dei ventenni suppongo non abbia confini precisi e forse va bene così, credo sia giusto a quell’età sentirsi a quel modo.
Non vidi più quell’uomo per tutta l’estate ma non ci feci caso allora, ero troppo preso da me stesso; ero davvero un ragazzo impegnatissimo.
Due giorni dopo la donna tornò, ma non ci feci caso, ero occupato alla vecchia tomba della Famiglia Canelli che stava per subire un restauro preventivo e la vidi solo quando stava andando via, uno scroscio di pioggia fredda aveva cercato di lambire l’angelo triste della piccola e la donna ne aveva difeso le spoglie terrene.
Ogni volta che arrivava mi prendeva come una fitta dolorosa al costato, ma era comunque un pensiero liminare, di quelli che ti passano vicino ma non sono davvero tuoi, il momentaneo e disperante vuoto che dura solo un secondo.
Vidi la strana madre ancora per una settimana poi il vortice pazzoide della vita dei ventenni mi colse in piena faccia, e finalmente il sole tornò a fare capolino in quella meravigliosa estate dove la pioggia era come sciolta nelle promesse d’autunno.
Quando mi resi conto che la donna non si vedeva più presi il coraggio e ne parlai con Stefanelli; gli raccontai di come la donna mi turbava: aveva spalancato le porte della mia percezione sulla completa pazzia. Avevo capito come gli interruttori si spengono con un rumore secco, ecco cosa mi sembrava quel pensiero. Un rumore sordo di qualche cosa che si frantuma senza lasciare intendere da dove provenga. Stefanelli mi disse che a volte succede ai beccamorti di avere dei sogni e di non preoccuparmi.
A dire il vero non avevo sognato nulla, ma il collega sembrava non rendersene conto, forse non mi ero spiegato bene, ma lasciai perdere perché eravamo molto occupati e i pensieri profondi da film horror non servivano a nulla.
Non so se ero rimasto condizionato da quello che Stefanelli mi aveva detto, ma due giorni dopo sognai per la prima volta.
Ero al cimitero e tutto sembrava reale, anche se continuavo a ripetermi che stavo sognando. Vedevo il viale alberato che gettava le sue ombre sulle tombe nel caldo del pomeriggio, sentivo le cicale e poi un tuono ruppe il silenzio estivo con grande fragore. Io stavo riposando in ufficio a occhi chiusi, ma sapevo di sognare nel mio letto; vedevo comunque quello che accadeva.
Poi, a un certo punto, mi accorgo che è notte e che mi sono addormentato veramente. E’ sceso il buio, sono rimasto solo e sono chiuso dentro.
Non ho le chiavi e il muro di cinta è vertiginosamente alto come se avessero aggiunto venti file di mattoni mentre dormivo e quindi era improbabile che io potessi scavalcarlo; aria gelida da nord solcava urlando il cimitero ed io avevo freddo e fame; sapevo che dovevo iniziare a correre e tentare di scavalcare, ma mi rendevo conto di avere le gambe pesanti. Provavo a correre, ma non ci riuscivo, erano piombate al suolo e stavo procedendo affannosamente; sentivo dietro di me il rumore fragoroso di centinaia di persone disperate che volevano uscire, avevo paura e volevo urlare ma ero muto. Dietro di me sentivo rumori fragorosi e spaventevoli, ma non potevo ne urlare ne scappare, pian piano stavo anche perdendo la vista.
Avevo paura, una paura fottuta quando madido di sudore ho aperto gli occhi, veramente, nella mia stanza. Benedissi la luce della luna che filtrava dalle tende.
Non lo raccontai a nessuno e la notte successiva sognai ancora il cimitero.
Questa volta però sentivo un artiglio che voleva scorticarmi la schiena, volevo urlare, ma la voce non usciva e questa volta il terrore saliva dal basso ventre.
Era buio ed io come la volta precedente ero rimasto chiuso in ufficio, una luce chirurgica proiettava l’ombra dell’artiglio che voleva la mia gola.
La paura era così reale che ho dubitato di essere sveglio; l’artiglio era sopra di me e sentivo il gelido afflato che voleva lambire le mie gambe quando finalmente, quasi morto di terrore, riuscii ad aprire gli occhi. Ero sveglio e sudavo freddo e le gocce sulla schiena mi facevano tremare. Mi resi conto che al basso ventre ero molto più bagnato: mi ero fatto la pipì addosso, l’ultima volta che era successo avevo due anni. Non lo dissi nemmeno alle anime dei morti.
Poi, due notti dopo feci l’ultimo sogno di quella strana batteria. Fu il più brutto di tutti.
Era come sempre notte, ma non capivo bene dove mi trovassi, non sentivo freddo o fame, ma avevo la sensazione di essere chiuso dentro ad un armadio perché sentivo l’aria mancare progressivamente come se qualcuno da fuori la stesse togliendo con un aspiratore, avevo le gambe pesanti e le braccia erano slogate all’altezza dei gomiti. La paura saliva a ondate concentriche e non sapevo nemmeno perché. A un tratto sentii un rumore a me molto familiare: il suono della terra che cade su una bara. Ero chiuso dentro la bara durante il mio funerale, ma non ero morto. Ero vivo e vegeto.
Come sempre cercavo di urlare e questa volta sentivo distintamente le mie urla forsennate che cercavano di contrastare il rumore allucinante della terra a pioggia che cercava di coprirmi. Il trattorino guidato da Cerletti faceva molto più rumore di me.
Lentamente l’aria stava finendo dentro quella cassa maledetta e nessuno poteva sentirmi, la disperazione era vera e pulsante perché nonostante sapessi di sognare credevo anche di morire. Me l’ero fatta di nuovo addosso e sapevo che appena sveglio, sempre che mi fossi svegliato, avrei avuto il letto bagnato; stavo piangendo per i peccati del mondo, per i miei peccati, per la mia famiglia e per tutti quelli che stavano assistendo al rito funebre. Aiuto.
Sentivo che fuori stavano cantando l’Eterno Riposo e il prete urlava che sarei bruciato all’inferno per il peccato mortale che avevo commesso, ero un corrotto che aveva rinunciato a Dio e meritavo di essere sepolto in terra sconsacrata lontano dagli angeli che non avrebbero mai cantato per me: dovevo solo bruciare e tacere per sempre, non meritavo nulla.
Questa volta ho urlato. Tanto forte che mi si sono rotti i capillari degli occhi e credo di aver svegliato gli inquilini del cimitero. Per fortuna ero solo in casa perché mi vergognavo come un ladro: avevo pianto nel sonno e avevo bagnato il letto. Dovevo sostituire il materasso prima che la vacanza a Misano dei miei terminasse.
La mattina dopo ero uno straccio e Domenichini se ne accorse subito, pensava che avessi festeggiato sino a tardi, ma guardandomi meglio si accorse che ero terrorizzato. Mentre preparavamo la tomba della maestra Venturoli iniziai a raccontare a fiume tutto quello che mi era successo.
Domenichini è un ragazzone alto alto e secco come un chiodo di dieci anni più vecchio di me che sa ascoltare il prossimo in silenzio religioso ed anche quella volta ascoltò tutti i miei deliri senza battere ciglio, senza pregiudizi e senza credermi drogato o pazzo come un cavallo; più parlavo e più lui sgranava quegli occhi grandi che danno l’impressione di non sbattere mai le palpebre, ma mi ascoltava senza ridermi in faccia.
Dopo la tirata il Vecchio, come lo chiamiamo noi, tirò un sospiro lungo e rumoroso poi come cercando la voce in fondo alla buca della Venturoli iniziò a parlare: – Vedi Chicky Baby, ( il mio orrendo soprannome ) sto per dirti una cosuccia che potrebbe non piacerti molto, ma devo. In fondo a noi ci piace no, parlare di certe cosuccie, no? Te non c’hai paura se te lo dico. Sai? Hai visto un fantasma. –
Lo guardai e gli risi in faccia così forte che credo di avergli rotto un timpano.
Allora il Vecchio mi prese il braccio e facendomi uscire dalla buca mi condusse nella parte nuova che all’epoca era stata appena terminata per mostrarmi una cosa che a suo dire mi avrebbe spento la ridarella. – Cinno[1], la vedi questa? Guarda bene questa lapide qui –
Quello che vidi mi lasciò vetrificato.
Non poteva essere vero, non poteva esserlo davvero.
La lapide in questione era nuova, ma non l’avevo posata io perché ero in vacanza a Cortina D’Ampezzo con Amanda e quindi non l’avevo notata, almeno a livello cosciente, ma la vidi in tutto il suo splendore mentre la raggiungevo. Mi sentivo come un malato di labirintite e la terra sotto di me tremava e ondeggiava, il mio peso era scomparso e la vista annebbiata.
Stavo per chiudere le porte d’entrata della mia percezione, ma non lo feci. Dovevo prendere atto della questione e accettare che Domenichini aveva ragione: avevo visto un fantasma.
Era una lapide grigia chiara, pulita e diametralmente opposta a quella dell’angelo vigilante all’entrata, ma avevano tantissime cose in comune: questa era la lapide della Madre della Ragazzina, morta suicida una settimana dopo l’incidente di Dicembre.
La madre di Dome era una cara amica della donna, Carmen Generali. La donna, disperata e distrutta dal dolore, non seppe sopravvivere a quella bambina morta a quindici anni su una strada fredda e piovosa prima di Natale. Continuava a pensare al cadavere della figlia sotto la pioggia che s’inzuppava e non si dava pace.
Lo urlava durante il funerale alla navata della chiesa ricolma di gente, urlava così forte da coprire l’omelia del prete e gridava che sarebbe andata all’inferno perché si sarebbe uccisa.
Tutti pensarono che fosse solo la voce della disperazione, ma sette giorni dopo il marito la trovò morta a letto intossicata dal veleno per topi: gli sfinteri avevano ceduto e si era fatta la pipì addosso.
Io e Domenichini tornammo in ufficio e per quel giorno decisi che avrei fatto festa.
Avvisai in comune e me ne tornai a letto.
A distanza di tanti anni mi chiedo ancora che cosa accadde in quei giorni piovosi d’estate, se davvero la mia esistenza abbia colliso con un fantasma o solo con un’Assenza. Ho vissuto il delirio di una morta, o magari il mio delirio, questo non riesco a comprenderlo.
Ancora oggi la notte prima di dormire ci penso, ascolto il mio cuore che parla con la follia, perché davvero compresi cosa vuol dire sbiellare e mi resi conto di cosa nasconde la mente umana quando permette al gorilla di rompere le sbarre e irrompere nel mondo.
Anche oggi che ho trent’anni e qualche capello bianco in più, ora che il tempo ha trasfigurato e sbiadito quei giorni strani, senza estirpare dal mio cuore il viso dolce di quella ragazzina morta d’inverno, mi chiedo se potrò mai salvarmi e non cadere nel baratro.
I sogni sono ritornati e sono molto peggio di otto anni fa.
Adesso l’artiglio lo sento, sulla schiena. Ogni notte gratta sempre un po’ più forte. Il muro è sempre più alto e le grida dei morti ogni volta più atroci.
Chiamano il mio nome, mi vogliono con loro. Urlo anche io, sempre più spesso.
Ci penso soprattutto ora che Amanda è incinta.
Sarà una bimba e nascerà a Dicembre.
[1] Cinno, bambino in dialetto bolognese.
Categorie: Libraio, Racconti, Scrittoio
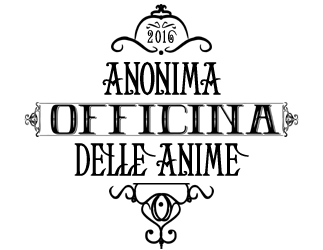



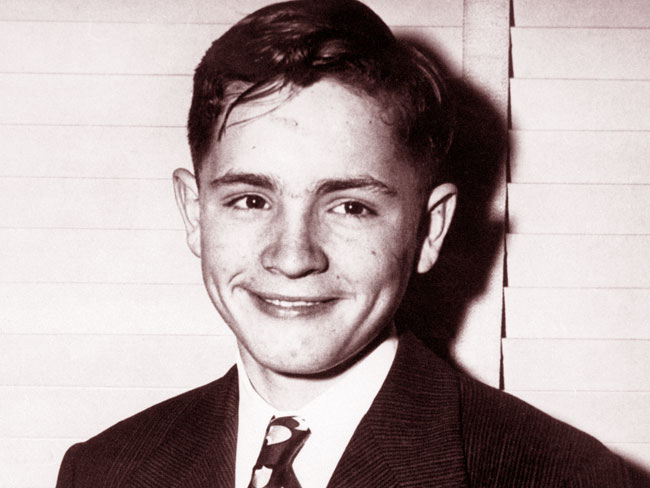
Lascia un commento