NAVIGATORE SATELLITARE NEL CUORE
Eccoci arrivati alla terza fetta di cuore che vi lascio, miei cari lettori e amici. Questo racconto è del 2011, scritto dopo aver acceso casualmente la tv. E’ successo davvero quello che racconto sul “Black Album” dei Metallica, il ventennale e tutto il resto. Per la prima volta mi sono sentito adulto (vecchio). Ho capito cosa vuol dire Casa anche ripensando alle parole di Hetfield durante un’intervista in cui diceva che l’amore è la casa dove sta il tuo cuore. Quando diventi adulto le cose cambiano e quindi decisi di scrivere questo racconto, dove solo le situazioni meno avventurose sono reali. Il resto, purtroppo o per fortuna, sono le mie vite di ricambio. Questo racconto mi fa commuovere, quindi, per favore, maneggiatelo con cura perché c’è un pezzettino molto intimo del mio essere….
Ah, finalmente mi sono deciso: alla fine del racconto troverete una scelta musicale. Se volete provare ad entrare nella testa (mattoide) del Capofficina, questo è il momento giusto.
Buona lettura….
Questa è la storia di un viaggio, o meglio, la storia di un ritorno. O forse la storia di un viaggio che non è mai iniziato o finito. Viaggiare è quello che conta e non la meta, quella non importa perché è già in fondo al nostro cuore, fa parte di noi appena nasciamo; veniamo su questo traballante mondo con uno scopo, con un Perché ben definito e deciso dall’Ufficio Distribuzione Destini.
Non importa quanto lontano si va da dove si è nati, perché Quel Posto ti accompagna sempre. Inevitabilmente. E’ lui a guidarti come se fosse un navigatore satellitare dentro al tuo cuore.
Il Tuo Posto è il navigatore GPS interstellare che porta il tuo corpo al luogo dove è destinato. E alle volte destinazione e punto di partenza del Viaggio coincidono. Sono la stessa cosa. Potrà magari succedere che la pioggia cada sulla terra o che magari nel tuo luogo non piova mai, che il secco distrugga tutto, ma questo non conta. Magari potrebbero piovere rane sui castelli di sabbia della tua anima ma devi andare avanti lo stesso, perché è quello per cui sei venuto al mondo.
Ho visto, o meglio ho Vissuto in luoghi mitici e lontani.
Ho scalato le Montagne sacre del Nepal, vissuto in monasteri lontani per cercare me stesso, sono stato in cima all’Everest per cercare di vedere il mio paese che da un po’ chiamano città ed ho avuto la sensazione di scorgerlo la in fondo, dove inizia l’arcobaleno e lo gnomo capo tiene il suo pentolone d’oro, mi è parso di vedere pure casa mia. Ma credo che questo dipendesse dal fatto che sono cose che ho dentro, non credo che la colpa sia degli ottomila metri d’altezza come dicono gli scienziati.
Non credo nemmeno che dipenda da certe sostanze additive che nel passato ho usato. Sono certo che Il Mio Posto Del Cuore si veda da ovunque. Perché è quello che ho in fondo agli occhi, è un’impressione retinica persistente e insistente.
Ho viaggiato in ogni punto d’incontro tra terra e cielo, ho visto luoghi remoti e avuto donne bellissime, non solo nelle mie fantasie. Ma alla fine quello che mi è rimasto dentro c’era da subito.
Il tempo che passa è come sabbia in fondo agli occhi, che impasta e costruisce mondi lontani e inesistenti. Il tempo che passa e che corre talmente in fretta che a volte non fai nemmeno a tempo ad accorgertene, così veloce che a volte non passa nemmeno. I tempi e i luoghi sono scie di aeroplano, bianche nubi lontane lassù.
Vengo dal 1977 assieme al punk. Vengo da Sasso Marconi e a volte ho come l’idea di non averlo lasciato mai, nemmeno per un attimo. Ho viaggiato: con l’immaginazione, col corpo, contro voglia e per scappare percorrendo enormi distanze dalla terra alla luna e ritorno. Ho visto e vissuto tanto ma non ho mai lasciato Sasso Marconi. Perché è il Mio Luogo.
E ora sono tornato, con mia moglie e i miei bambini.
È una storia strana, quella che vi racconto. Non è solo la storia di un viaggio, ma è anche un pezzo della mia vita pazza e disperatissima attraverso gli anni, il tempo e l’amore che ho ricevuto e dato. Sono solo un po’ più vecchio di quando sono partito: ho rughe che prima non avevo nemmeno l’idea potessero formarsi in certi luoghi della faccia, sono più lento, di poco, ma pur sempre un po’ più pesante di allora; oggi sono un uomo che ne ha viste tante, che ha vissuto, sentito e creduto, toccato, annusato, tentato, provato. Diverso solo per chi non ha mai guardato nel fondo dei miei occhi.
Erano le nove del mattino, il primo giorno d’Agosto, il terzo dal mio ritorno.
Accesi il televisore e mi sintonizzai sul comando per decidere la programmazione quando mi colpì in pieno petto quella canzone. Erano almeno due anni che non ascoltavo quella canzone e non sapevo nemmeno perché fosse passato così tanto tempo dall’ultima volta.
Mi ero sintonizzato giusto in tempo per sentirla dall’inizio, per prendere una scudisciata in pieno viso, per sentire una lacrima formarsi nell’angolo destro degli occhi.
Ricorreva il ventesimo anniversario del “Black Album” dei Metallica.
Mi resi conto che ero vecchio. A trentaquattro anni si è uomini ed io lo sono molto più di altri.
Ho vissuto le estremità di ogni cosa senza rimpianti, perché la vita che si è vissuta non è soltanto parte di noi ma è decisa con i gesti, le parole, le scelte giuste o sbagliate e tornare indietro è cosa per vigliacchi e per falliti. E fin che abbiamo fiato nei polmoni, non siamo falliti. Solo la morte è un fallimento quando arriva troppo presto. Quando non si è fatto quello che il destino aveva in serbo per noi, solo allora il fallimento e la condanna ti colpiscono, e una nuova esistenza per redimere quel destino incompiuto non è più possibile. Ero vecchio, o meglio ero un adulto con tanta vita dietro in quel momento. Pensavo al “Black Album”, ai miei capelli lunghi rasati di fianco, al primo tatuaggio prima di lasciare la scuola e all’ultimo giorno a Sasso prima di partire per chissà dove passato a fumare sigarette e bere birra su alla ghiacciaia col Folle e Pippo, per farmi coraggio perché avevo una fifa blu. Fuori dall’azzurro, dentro al nero.
Ricordo il fischio del treno che mi portava alla stazione di Bologna, sento ancora l’odore delle ruote dei treni, il puzzo caldo che dalle gallerie viene su quando non chiudi i finestrini.
Ero terrorizzato dalle gallerie, lo sono ancora oggi perché il caso volle che mi salvassi da due delle più grandi tragedie ferroviarie d’Italia, ma queste sono altre storie ancora e ve le racconterò un’altra volta. Ero un bimbo e forse i miei ricordi sono sfuocati e disturbati, vi basti sapere che nonostante il terrore sacro ho usato spesso il treno, solo in casi rari ho usato l’aereo e la patente l’ho presa quando mi sono sposato tre anni fa perché non mi sembrava bello che mia moglie, col pancione, mi scarrozzasse.
Avrei iniziato le scuole superiori quell’anno, ma nell’estate del passaggio presi una decisione da fricchettone: avrei girato il mondo. Lo comunicai ai miei e loro risero come matti e decisero che si, potevo fare una vacanza con mia sorella e mia cugina. La vacanza in questione durò tutta l’estate e li convinsi a mandarmi a studiare prima un anno a Londra, poi uno a Parigi, sino al salto di qualità: due anni in Australia.
E da lì nessuno seppe più fermarmi, avevo diciassette anni e una gran testa di cazzo.
Ero, sono, come avrete capito, un fottuto figlio di papà che non ha mai voluto esserlo davvero, ma pressato dall’immenso ego e dall’egoismo che mi contraddistingue decisi che i soldi sarebbero stati il mio mezzo di trasporto per il mondo intero e così è stato. Ho fatto delle stronzate immense che mi hanno portato anche a farmi del tempo in galera e vi assicuro che non mi sono divertito ma ho pagato tutto senza lo sconto, perché i coupons erano terminati, ho pagato e vissuto e non chiedo di meglio.
Amo la vita con tutto me stesso e non la cambierei per nulla al mondo. Anche i miei concittadini, almeno quelli che di me serbano memoria, sono stati felici e scioccati nel rivedermi, nessuno credeva che sarei tornato.
I miei genitori credevano scherzassi il giorno che mi presentai da loro con i capelli corti e del mio bel biondo naturale, con moglie e bimbi al seguito; pensavano fossi un impostore e che loro figlio fosse morto. In famiglia molti parenti ci hanno sempre considerato reietti a causa del nostro strano modo di vivere la vita e i rapporti: mio padre, che ha sempre avuto un gran senso dell’umorismo, ci aveva fatto confezionare delle magliette tutte nere con la scritta rossa: “Black Sheeps”che indossavo il giorno del mio ritorno. Era tutta sbiadita, con piccoli buchi, ma lo fece piangere.
Lo vidi solo il giorno del funerale di nonno piangere sommessamente e allora avevo sette anni. A farlo commuovere non era il mio strano ripresentarmi, in fondo a quello erano abituati; ogni tanto tornavo furtivamente a casa, ma non avevo mai più indossato quel vecchio straccio che significava “Casa”, “Amore”, “Appartenenza”.
Era la bandiera dello Stato Libero di Paceamorefantasia, come lo chiamava mia sorella Carolina e stava a significare che ero davvero tornato, che ero a Casa e non a casa e che adesso il mio cuore appartiene davvero non più a me, ma a tutti quelli che mi hanno amato e che mi amano.
È la storia di un viaggio dentro il cuore di tutto quello che conta davvero. Ho visto, vissuto, mangiato, respirato lontano da tutti e tutto, me compreso, e alla fine ho capito. Cose che molti di noi imparano stando fermi io le ho capite via da qua, me ne sono ricordato perché tutti noi le abbiamo già dentro, ma alle volte le nascondiamo per pudore, orgoglio, paura, distrazione, pigrizia o solo perché la vita alle volte è troppo faticosa.
Sono stato un ragazzino precoce ma troppo ambizioso per Capire la verità intrinseca della vita, quel senso di vuoto che mi prendeva e spingeva sempre più lontano, sempre più verso cose che non mi appartenevano e che cercavo disperatamente di far mie, solo per potermi sentire vivo nel mondo.
Avevo già tutto e non me ne rendevo conto.
Il GPS interno mi aveva riportato a casa e il “Black Album” era solo il promemoria.
Ero a casa da solo quel mattino e mi stavo preparando per andare in ufficio, adesso che mi sono civilizzato lavoro con mio padre; non so come ma nelle mie vite precedenti sono riuscito pure a prendere la sospiratissima laurea in giurisprudenza. Stavo cercando di fare il nodo alla cravatta, anche se come sempre sarei arrivato in studio con la stessa a mo’ di sciarpa; mio padre dice che gli ricordo un pianista jazz, una vecchia canaglia senza regole e bé, non ha torto.
Quelle note che riempivano la stanza attraverso l’home theater erano tutte attorno a me come lucciole di un tempo andato, suoni fantasma di un ragazzo morto da tempo che cercava di tornare al mondo dei vivi, ricordi dolci come il sapore del sangue versato, la porta del paradiso aperta e subito richiusa. Stavo piangendo e non me ne ero nemmeno accorto.
Le lacrime calde del dolore quando diventa squisito e lontano, un vago sentore di mal di stomaco che sale su fino all’esofago e ti chiude la gola, ti fa pensare a qualcosa che avevi dimenticato e credevi di aver perduto. Una malinconia delicata e silenziosa come un sospiro, un vago sentore di lacrime calde nella notte, la consapevolezza che in fondo nulla è più la stessa.
Sapevo di essere ancora quel ragazzo di un tempo che voleva solo sognare: l’unica differenza tra me e lui era che io avevo sognato anche troppo, fino alle estreme conseguenze.
La musica è da sempre una parte di me: non ho mai imbracciato nessuno strumento, ma la passione è così grande da far suonare ogni centimetro della mia anima. Potevo saltare un pasto per acquistare le pile del lettore cd o fare cose folli per ricaricare il lettore mp3. Ogni secondo ha suonato solo per me ogni tipo di emozione, per non smettere mai di avere una colonna sonora ai pensieri e non dimenticare di essere ancora vivo. In galera mi ha salvato tenendomi compagnia, sull’Everest soffrivo di mal di testa, ma era comunque dentro e non si fermava mai.
La nostalgia o la gioia erano scuse valide per cantare; non sono male come cantante ed è come respirare, se sei solo senti il rumore dei tuoi pensieri uscire dalla bocca.
Ogni luogo ha la sua colonna sonora: Londra con i Clash (lo so, lo so banale ma sincero), Parigi con i Megadeth, Praga e Mosca coi Metallica, L’Everest ha i Boston, “More than a feeling”, San Diego i Led Zeppelin, Los Angeles con gli Slayer, Sidney ha Beethoven e Verdi, il Nepal con gli Hanoi Rocks e Adam and the Ants, il Canada con i Kiss, i Cure e i Dream Theater. E non chiedetemi perché che non posso darvi.
I Metallica sono sempre stati i miei preferiti e lo sono ancora.
Non esiste un motivo concreto: l’amore non si discute perché è una questione di chimica e a volte ho la sensazione di essermi innamorato di mia moglie perché la prima volta che la vidi aveva una succinta maglietta di Kill’em all, il loro primo album addosso. Le mie colonne sonore non sono originali, ma sono mie.
E’ come se ogni pezzo sia stato scritto per me da qualcuno che mi conosceva prima di Dio, per rendermi il cammino su questo mondo meno doloroso, ogni sapore, odore o dolore che si portano dietro fanno parte di qualcosa che è più grande e vecchio di me, la musica è la sostanza di cui sono fatto. Ho vissuto a lungo credendo che alla fine sarei diventato una rockstar, che sarei stato l’astronauta più giovane, lo scalatore più famoso del mondo e il più grande cuoco di New York.
Ci sono stato due anni ed ho conosciuto più italiani affamati lì che in Autogrill al Cantagallo.
Sognare di essere più maschio di Hemingway, più veloce di Lewis, più scaltro di Kasparov e più bravo di Viveros. Ho sognato vivendo dentro quelle illusioni che mi portavano dappertutto lasciandomi nel niente, senza rendermi conto che avevo visto quasi tutto su questo pianeta tranne il mio vero essere. Avevo conosciuto ogni sorta di personaggio, ma non avevo mai incontrato Me Stesso. Poi, una fredda mattina di Marzo a Renton incontrai il Mio Destino.
Stavo cercando la tomba del Mancino, come la metà della gente che si reca al Greenwood Memorial Park, quando una ragazza biondissima mi sbatté contro, insultandomi in dialetto bolognese. Non potevo credere alle mie orecchie, erano almeno sei anni che non sentivo parlare nella mia vera lingua e la guardai come se fosse piovuta da Vega senza il biglietto d’imbarco: le risposi per le rime e lei scoppiò a ridere così forte che i parenti dei defunti ci guardarono, anzi ci attraversarono con cattiveria. Le dissi solo. “Piacere mia cara sboccatona, io mi chiamo Elia Savini e sono originario di Sasso Marconi”. Lei mi guardò come si osservano i reperti archeologici e mi disse, circa con lo stesso tono:” Buon giorno Elia Savini, sarai mica il fratello della Carol?”.
Sorpresa: mia moglie era la compagna di banco al liceo di mia sorella maggiore, inseparabili per cinque anni. Lei ovviamente si ricordava di me che ero un “cinno”, io di lei serbavo un vago ricordo: tra me e lei ci sono sei anni di differenza e quando divenni più grande i nostri mondi erano lontani.
Dopo l’università, facoltà di Agraria, Eva partì per l’America grazie ad una borsa di studio per un master, dove conobbe il suo primo marito e con lui la vita dura di campagna fatta di alcol, botte e umiliazione. Era scappata una notte qualche tempo prima, aveva indossato la sua splendida magliettina sexy dei Metallica sotto il chiodo di panno bianco (era vegetariana da vent’anni) e aveva iniziato a girovagare per l’America nascondendosi sui treni merci. Voleva visitare anche lei la tomba di Hendrix e aveva il terrore di tornare a Casa, quella vera, in Italia, per la paura del giudizio e per la vergogna: una laureata che ha giusto saputo sposare un ubriacone violento. Eravamo andati a prendere un caffè da Starbuks e mi disse tutte queste cose in meno di dieci minuti.
M’innamorai subito dopo la fine del suo racconto, che doveva essere strappalacrime ma Eva è una commediante nata e mi tenevo lo stomaco dal ridere, se li accanto ci fosse stato un italiano mi avrebbe considerato uno psicopatico sadico. Mia moglie è fatta così, sa trovare il lato comico anche davanti alla morte, non sa piangersi addosso, come a volte invece ho fatto io: piagnone e coglione, come dice lei. Eva riesce a trovare la forza anche quando sembra che non ce ne sia, è lei la dura del gruppo.
Iniziammo il nostro viaggio dentro l’America assieme, come due fratelli di sangue, compagni silenziosi dei nostri sogni e non le dissi mai quanto forte mi battesse il cuore ogni volta che incrociavo quel suo profilo sottile e latteo, quel sorriso aperto, lucente e senza paura, il suo respirare piano piano per non svegliare i folletti la notte, non sapeva che l’amavo come mai nessuno prima e che non l’avrei lasciata più. Ho fatto il coglione per troppo tempo e decisi che non avrei fatto i miei soliti numeri anche questa volta.
Le raccontai tutto: dai viaggi pazzi alla droga, il mio fuggire e le paure di diventare adulto, condividevamo tante cose; nonostante tutto non ricorse mai alla merda che mi ero sparato a lungo. Decisi che non ne avevo più bisogno due anni prima di conoscerla, mentre ero in Birmania. Di fronte al meraviglioso che avevo davanti agli occhi, mi resi conto di tutta la mia stupidità; il buddhismo mi fu di grandissimo aiuto e grazie alla forza di volontà non mi feci più. Non ero rovinato, ma poteva capitare in breve tempo se non mi decidevo: per la prima volta nella mia folle vita presi una decisione assennata, forse l’unica.
Viaggiavamo assieme da sei mesi quando sotto le cascate del Niagara lei mi stava leggendo un pezzo di “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller con un’enfasi estatica da apparire quasi comica. Avevamo le mantelline gialle tutte piene di schizzi, la sua le stava d’incanto, come se glie l’avessero cucita addosso, mi pareva di vedere la Venere di Botticelli; le baciai la fronte e le dissi piano: ” domattina partiamo per Las Vegas, questa volta con un volo, ho i biglietti in valigia assieme allo smoking perché domani sera ci sposiamo”.
Lei continuò a leggere ancora per un minuto buono, poi come se si fosse ripresa da un lungo coma, mi guardò negli occhi e si mise a ridere, rideva fortissimo e tutti ci guardavano, allora glie lo chiesi a voce altissima; una coppia di anziani vicino a noi guardò ed io lo ripetei in italiano, loro sorrisero delicatamente e la signora le disse, in uno stentato italiano di accettare.
Eva rispose che a questo punto non poteva rifiutare.
Quattro mesi dopo possedevamo una piccolissima casa di due stanze a Bolzano. E’ la montagna, il nostro grande amore in comune. Una mattina calda e limpida mi guardò negli occhi e mi fece vedere un esame del sangue. Eravamo incinti. Avremmo saputo solo tre mesi dopo che eravamo doppiamente imcinti, due maschiacci. Quindi diventai “adulto” e mi decisi di chiedere a mio padre un lavoro, non dissi nulla né di Eva né dei bimbi, volevo far loro una sorpresa.
Una volta finita la stagione estiva lasciammo Bolzano e il mio lavoro di cameriere alla volta di Casa. I nostri familiari non sapevano nulla e quindi decisi di fare il cosiddetto”Colpo Grosso”.
Dissi tutto a mia sorella che non stava più nella pelle e venne prenderci direttamente a Bolzano. La prima cosa che fece fu darmi un ceffone e poi un lunghissimo abbraccio: piangemmo come due vecchie comari, senza vergogna ci tenemmo per mano e tutto fu come se non fossi mai partito, lei ed Eva si tennero strette per tutto il viaggio, avendo tra le braccia un ragazzino a testa.
I figli hanno nomi americani in onore del paese che li ha fatti nascere e dei nostri idoli musicali: James e David ed entrambi sono biondi, se imparano a suonare la chitarra e cantare avremo una dolce e roccheggiante vecchiaia.
Carolina aveva organizzato tutto come solo lei sa fare: non so bene come aveva invitato anche i genitori di Eva, con una scusa banale a me non chiara era riuscita a radunare tutti i più intimi, amici inclusi. Appena a casa mi è sembrata irreale ogni cosa: le voci, le lacrime, le risate di gioia, non so bene come spiegare il vortice che mi aveva colto; la sensazione di sogno mai finito, un già visto e mai finito, la sensazione di non essere mai partito.
Mi sentivo la testa leggera e pesante, galleggiavo sopra di tutti e avrei voluto non smettere mai.
Mio padre era senza fiato, mia madre piangeva mentre i genitori di Eva erano scioccati: l’avevano lasciata nell’Iowa, vicino a Des Moines come moglie di un contadino maleducato e la ritrovavano in Italia con un nuovo marito e due neonati; erano senza parole, ma felici.
Da allora penso ogni giorno a quello che ho perduto e quello che ho trovato: dovrei dire che la vecchia vita è malvagia e malata, ma non è così, no. Ho tantissimi bei ricordi e tante lezioni di vita da trasmettere ai miei figli, ho tanto dolore che a volte ritorna e la paura del futuro non è più così brutta, anzi, adesso la Paura non fa più paura perché da lei ho imparato che sono vivo e che posso andare dove voglio: perché ora ho la mia Casa.
Quel mattino mi resi conto che vent’anni sono un secondo e una vita intera, vite senza fine che ci portiamo dentro, nostre e di altri, momenti così importanti che nemmeno te ne accorgi.
Ho vissuto più io in trentaquattro anni che moltitudini di persone; non sempre ho vissuto bene, ma ho messo un’intensità tale in ogni attimo che a volte mi gira la testa, da quanto pesa.
Ho imparato dai miei errori, ho sbagliato, sono caduto e mi sono rialzato senza paura, senza più dover scappare via per trovarmi, perché quel giorno splendido vicino a Seattle ho trovato la mia Casa. Alle nove e zero quattro sapevo bene che il tempo si ferma e gira, corre su se stesso e ti riporta dove vuole, avevo imparato una nuova lezione, di certo ne avrei fatto tesoro.
Spensi la tele e mi avviai alla bici con la cravatta sulle spalle come un grande regista del muto.
E come diceva James Hetfield così vicino, non importa quanto lontano, non potrebbe venire più dal cuore, confidiamo per sempre in ciò che siamo e null’altro importa.
Categorie: Libraio, Racconti, Scrittoio
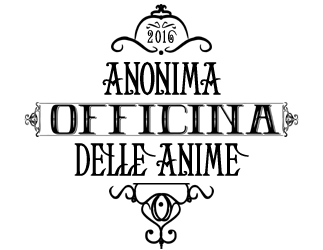



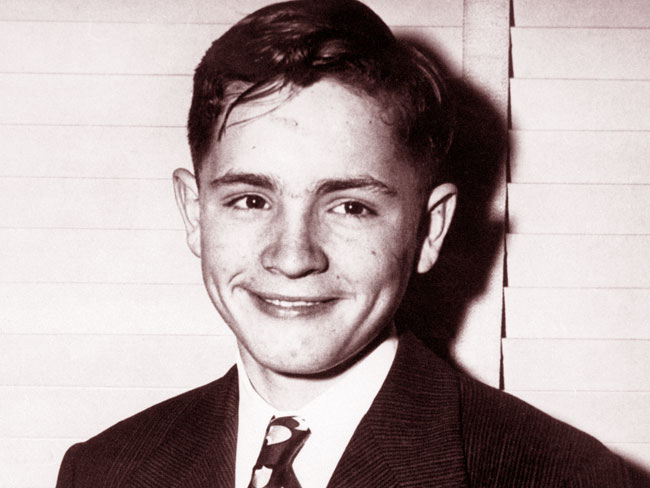
Lascia un commento